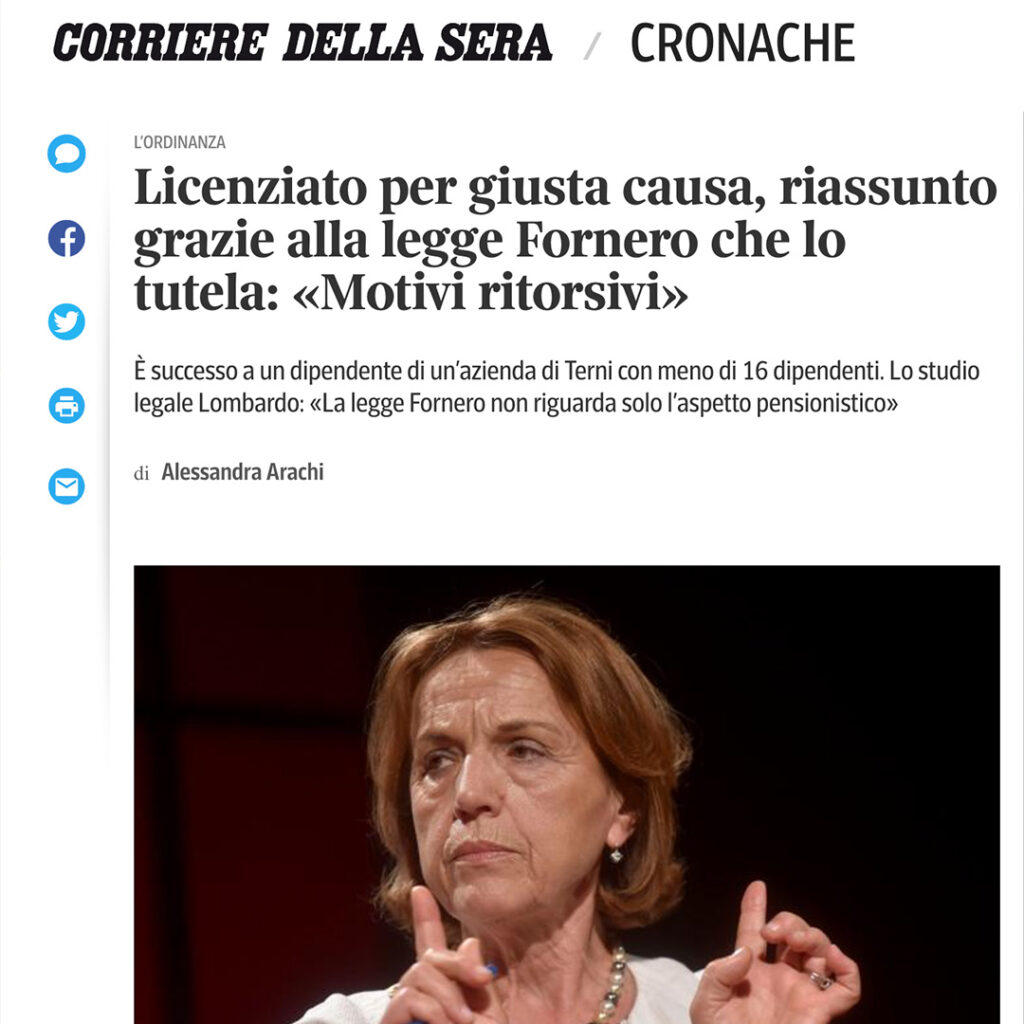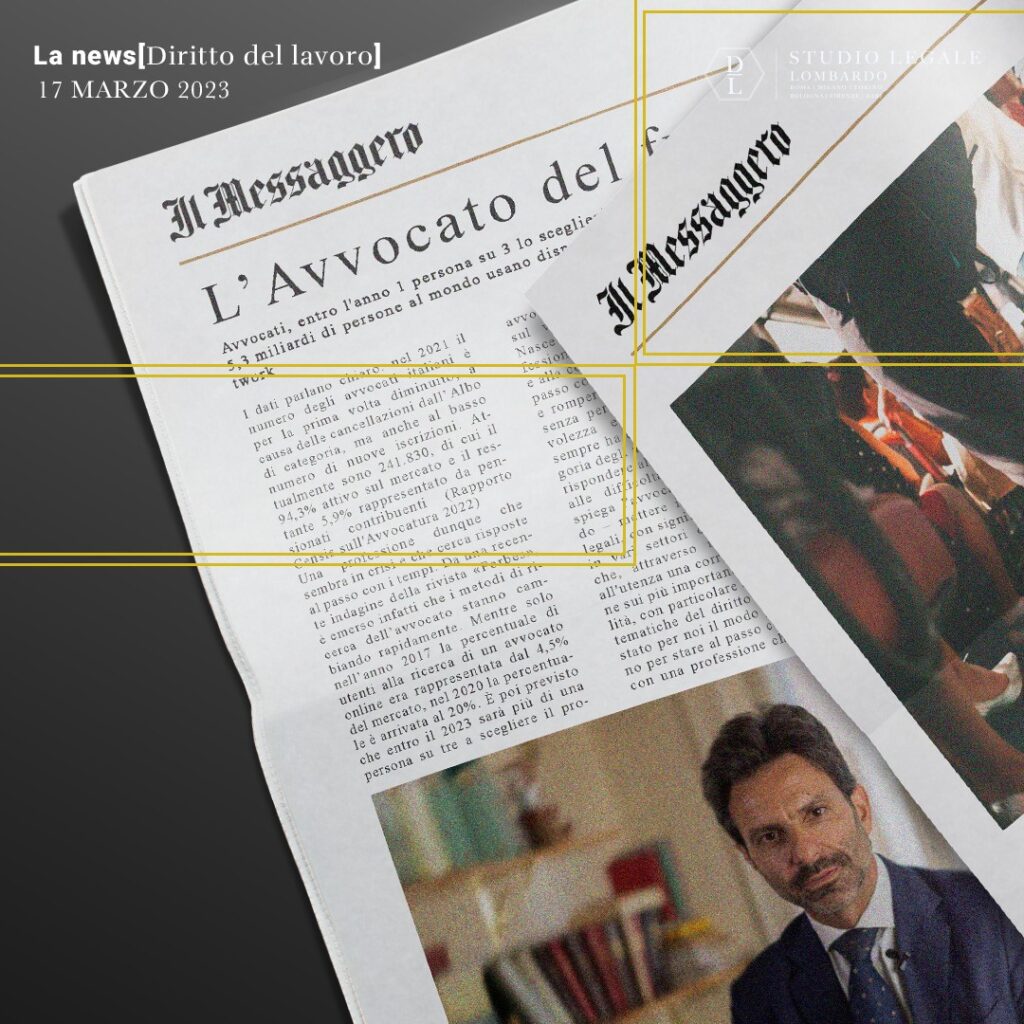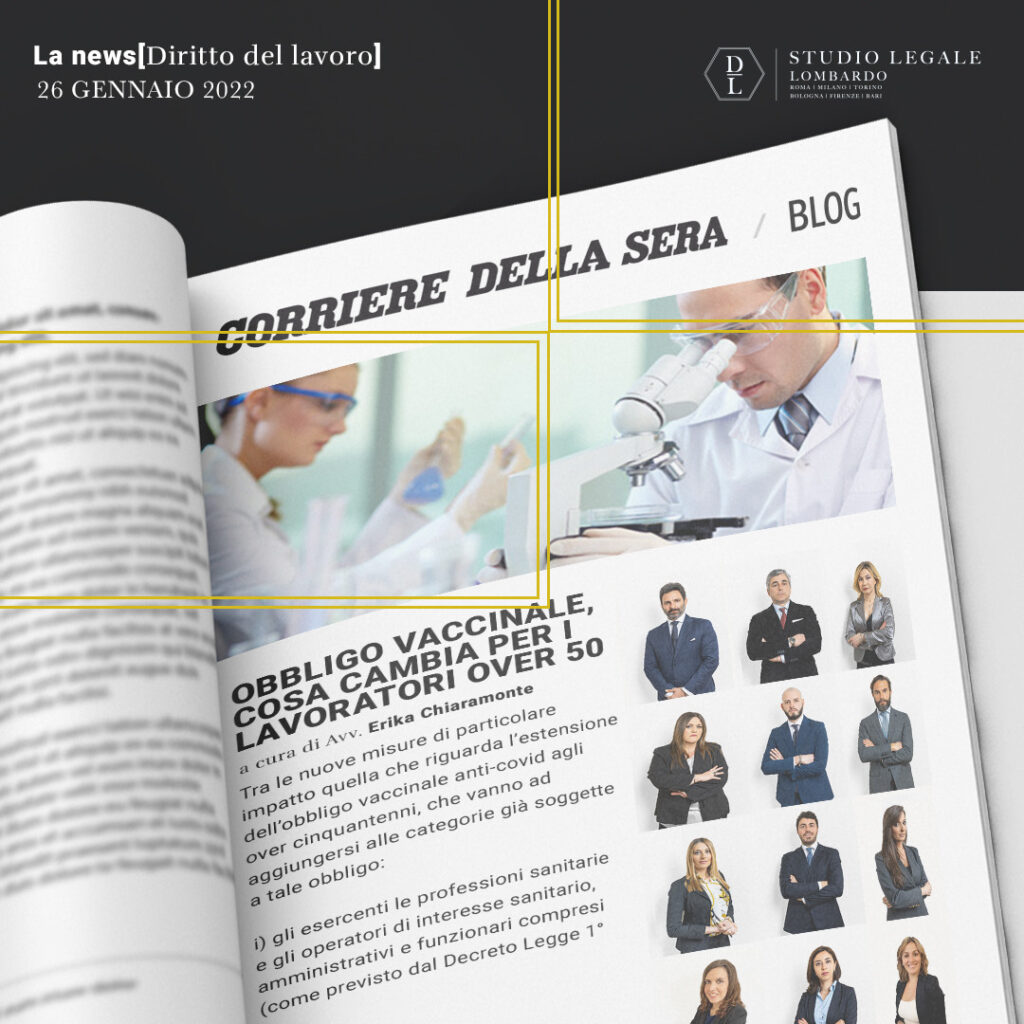Cosa si intende per mobbing per induzione alle dimissioni?
Da tempo, all’interno dell’ambiente lavorativo si stanno riscontrando, con una preoccupante frequenza, comportamenti tesi all’umiliazione, alla mortificazione e alla marginalizzazione del dipendente, così gravi da provocare disturbi di natura psico-fisica, danni alla salute e alla personalità.
Tale fenomeno prende comunemente il nome di mobbing.
Il mobbing e l’induzione alle dimissioni sono strettamente collegati, in quanto i comportamenti vessatori e persecutori messi in atto da colleghi o superiori e finalizzati unicamente a danneggiare il dipendente, spingono quest’ultimo a lasciare volontariamente il proprio posto di lavoro.
A tal proposito, merita un accenno la sentenza n. 87/2012 con la quale la Cassazione civile descrive proprio tale logica correlazione tra “la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale”, e “l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” che provoca, quale conseguenza, l’allontanamento intenzionale del lavoratore dal proprio posto di lavoro.
Come si manifesta il mobbing per spingere alle dimissioni o al licenziamento?
Il termine mobbing designa, secondo la giurisprudenza costituzionale “un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione, finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l’esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti ne è destinatario e vittima” (Corte cost. n. 359/2003).
Da ciò ne consegue che, ai fini della configurabilità della condotta mobbizzante posta in essere in danno del lavoratore, occorre il verificarsi delle seguenti condizioni:
Molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio realizzati in modo sistematico e prolungato contro il dipendente;
Intenzionalità offensiva dei comportamenti e degli atti posti in essere nei confronti del soggetto mobbizzato;
Potenzialità lesiva dei comportamenti;
Frequenza e durata degli atti persecutori, ovvero la loro continuità in un determinato arco temporale;
Configurazione dell’evento lesivo relativo alla salute e/o personalità del dipendente;
Nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;
Quali sono i diritti del lavoratore vittima di mobbing?
Il nostro ordinamento, pur disponendo di una serie di strumenti volti a garantire la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (vedi art. 32 Cost.), non ha ancora regolamentato, con una specifica disciplina legislativa, il fenomeno del mobbing.
Manca, in particolare, tanto una qualificazione giuridica della fattispecie, quanto un vero e proprio apparato sanzionatorio.
Pertanto, il lavoratore mobbizzato dovrà fare riferimento alle tutele contenute nelle norme già esistenti nel vigente ordinamento giuridico civile e penale.
Le principali protezioni legali sono:
Art. 2087 c.c.: il quale consente di imputare direttamente, e in tutti i casi, la responsabilità del danno da mobbing al datore di lavoro, tenuto a garantire l’integrità psicofisica dei propri dipendenti; in particolare, sul datore di lavoro grava l’obbligo di impedire, vigilando, eventuali atti e/o comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere dai suoi collaboratori nei confronti dei loro sottoposti, ma anche dagli stessi colleghi del dipendente;
Decreto legislativo n.81/2008: il quale impone ai datori di lavoro di adottare misure preventive per prevenire il mobbing e di intervenire tempestivamente in caso di emergenza
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): sancisce il diritto dei lavoratori a lavorare in un ambiente rispettoso della loro integrità psicofisica e vieta qualsiasi forma di discriminazione e molestia, compreso il mobbing.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: i cui articoli sono specificatamente dedicati al contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro;
Testo Unico per la sicurezza sul lavoro: il quale, all’art.28, impone di considerare tra i rischi per la salute dei lavoratori anche quelli derivanti da condizioni di stress da lavoro-correlato;
Decreto legislativo n.151/2015: ha introdotto il reato di “molestia morale” nel Codice penale, punendo chiunque commetta atti persecutori o vessatori nei confronti di un lavoratore ed esponendo i responsabili al rischio di risarcimento dei danni provocati.
Fondo di Solidarietà per le Vittime di Mobbing: offre supporto economico e psicologico alle persone che hanno subito violenza psicologica sul lavoro.
La violazione di tali normative fa scattare in capo al lavoratore la possibilità di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
I danni psicofisici causati dal mobbing vengono considerati come danni che devono essere indennizzati dall’INAIL, al pari di tutte le malattie professionali (Cass. n. 8948/2020)
Pertanto, l’INAIL si farà carico di risarcire tanto le lesioni biologiche, quanto le diminuite capacità lavorative del dipendente, determinate dai comportamenti mobbizzanti subiti.
Per tutti gli altri pregiudizi, e in tutti i casi in cui vi sia assenza di danno biologico, l’INAIL non interviene. Per questi profili, dunque, sarà necessario azionare la tutela civilistica, in persona del Giudice del Lavoro.
Si precisa, inoltre, che il datore di lavoro potrà rispondere dei comportamenti vessatori anche degli altri suoi dipendenti.
Dimissioni per giusta causa a seguito di mobbing
Quando un lavoratore si dimette a causa del mobbing, queste dimissioni vengono considerate come “dimissioni per giusta causa”.
Le dimissioni per giusta causa di verificano quando il lavoratore decide di cessare il rapporto di lavoro a causa di comportamenti gravemente lesivi inflitti del datore di lavoro.
In tali casi, il dipendente avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti, nonché l’indennità di disoccupazione (NASPI).
Quanto al risarcimento, il mobbing può far scattare sia una responsabilità di tipo contrattuale che extracontrattuale; la responsabilità contrattuale si configura quando viene violato il generale obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, come ad esempio nel caso di violazione dell’art.2087 c.c.; mentre la responsabilità extracontrattuale si configura quando la condotta mobbizzante è posta in essere da un soggetto non legato da un vincolo contrattuale con la vittima di mobbing, come nel caso di comportamenti vessatori tenuti dai colleghi.
Il lavoratore mobbizzato potrà, pertanto, agire in giudizio al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità per i danni subiti, ottenendo così un risarcimento integrale sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Ricorso e tutele legali in caso di mobbing e dimissioni indotte
Qualora il lavoratore sia convinto di subire condotte mobbizzanti all’interno del proprio ambiente lavorativo così gravi da indurlo a dimettersi, potrà ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di ottenere una tutela legale.
Dal momento che l’onere della prova è posto a carico della vittima, sarà essenziale reperire ogni prova utile (e-mail, messaggi, testimonianze di colleghi, nonché qualunque documentazione) idonea a supportare la sua causa in giudizio.
Per i danni alla salute, fondamentali sono i documenti medici; mentre, per i profili persecutori, oltre alle prove scritte, saranno determinanti le prove per testimoni.
Il mobbizzato dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrare che nei suoi confronti è stata perpetrata tutta una serie di comportamenti persecutori, con intento vessatorio in un arco di tempo medio-lungo, tanto da rendere invivibile il contesto lavorativo.
Il ricorso è presentato direttamente al Tribunale del Lavoro.
Tuttavia, in alcuni casi, il dipendente potrà richiedere una tutela cautelare urgente ex art.700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento immediato a tutela della sua salute e dignità.
Casi giurisprudenziali sul mobbing e le dimissioni forzate
L’art. 2087 c.c. si applica non solo se il mobber è lo stesso datore di lavoro, ma anche quando è un collega, ciò perché il datore di lavoro ha il “dovere di intervenire per rimuovere la situazione non più tollerabile all’interno dell’ufficio o azienda, onde evitare un’ulteriore lesione della personalità fisica e morale del lavoratore”. (Trib. Roma n.8357/2018).
È stato altresì precisato che “del mobbing risponde comunque contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, anche laddove le condotte lesive siano state poste in essere da colleghi di lavoro tramite il cd. mobbing orizzontale, in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse o potesse sapere quanto accadeva. Tuttavia, la responsabilità datoriale non elide quella dell’autore materiale del fatto, ma si aggiunge alla stessa, atteso che l’autore materiale, se diverso dal datore, in base ai principi generali, risponde comunque extra-contrattualmente ex art. art. 2043 c.c. del danno ingiunto cagionato con dolo o colpa” (Trib. Ivrea 2.12.2006).
Da non confondere con il fenomeno del mobbing, è il fenomeno dello straining, definito dalla giurisprudenza di legittimità come “una forma di mobbing attenuata caratterizzata da una singola azione stressante per il lavoratore, dalla quale derivino, comunque, effetti negativi duraturi nel tempo” (Cass. n.15159/2019)