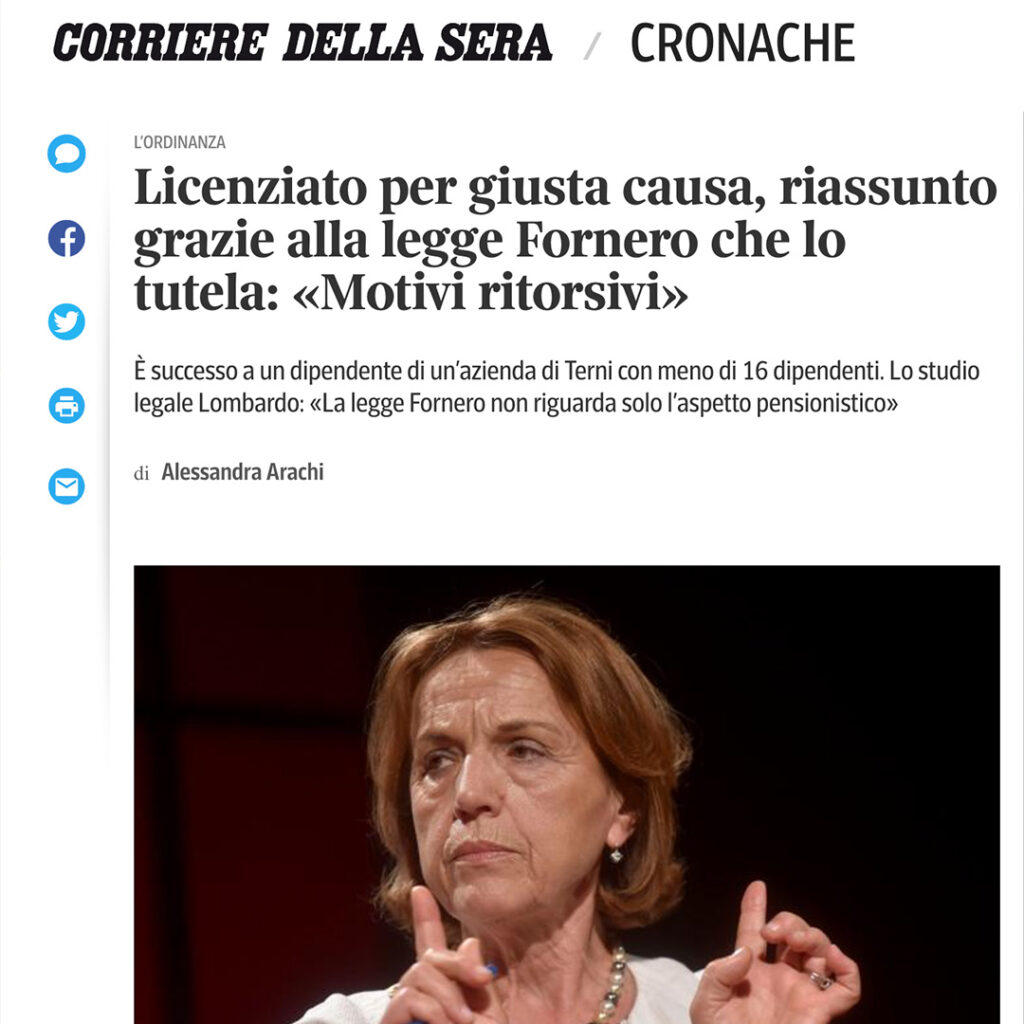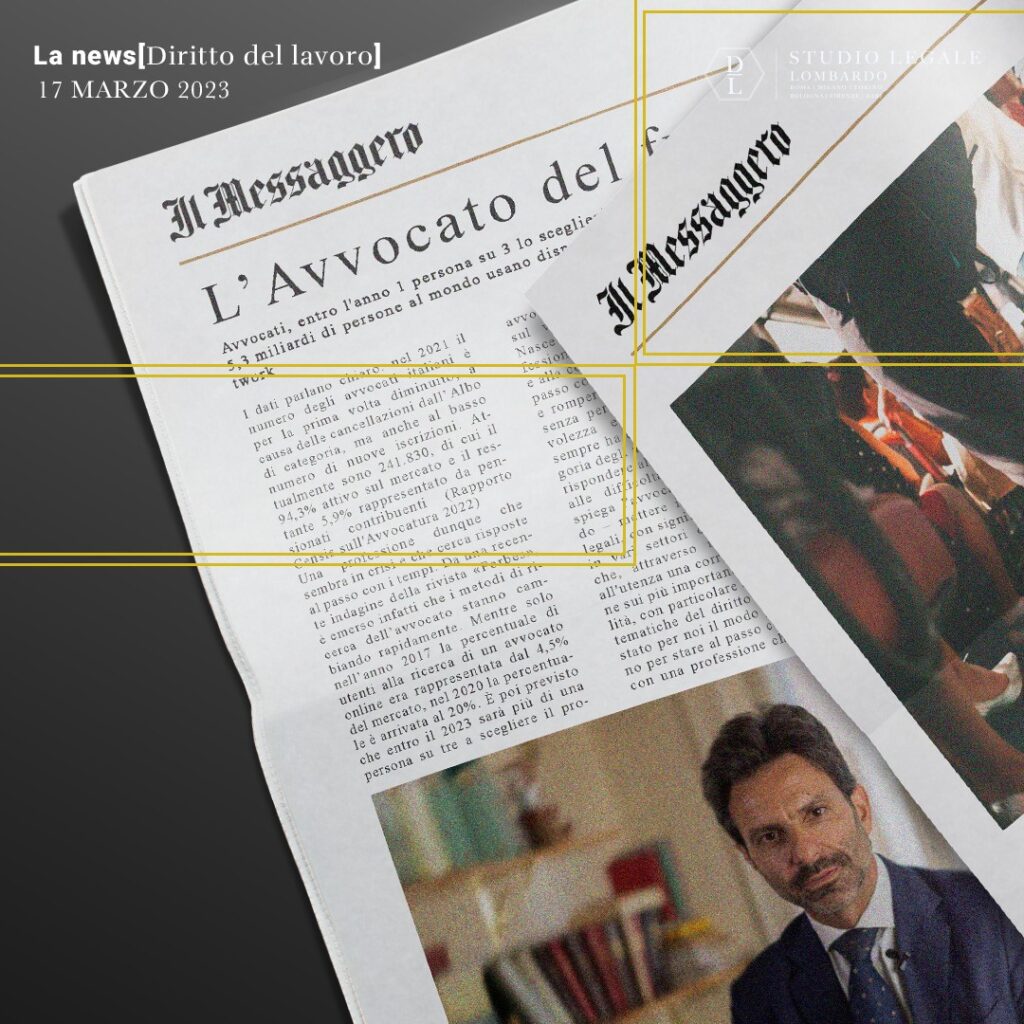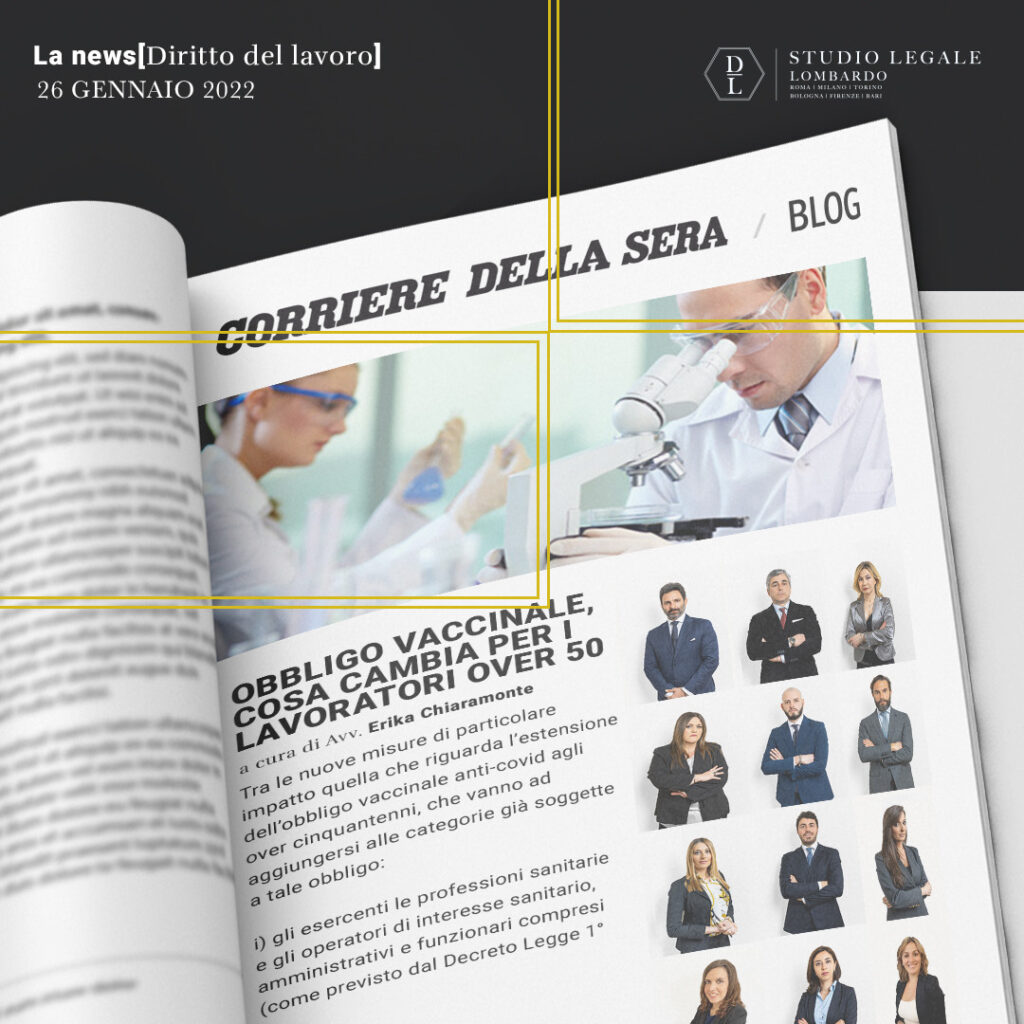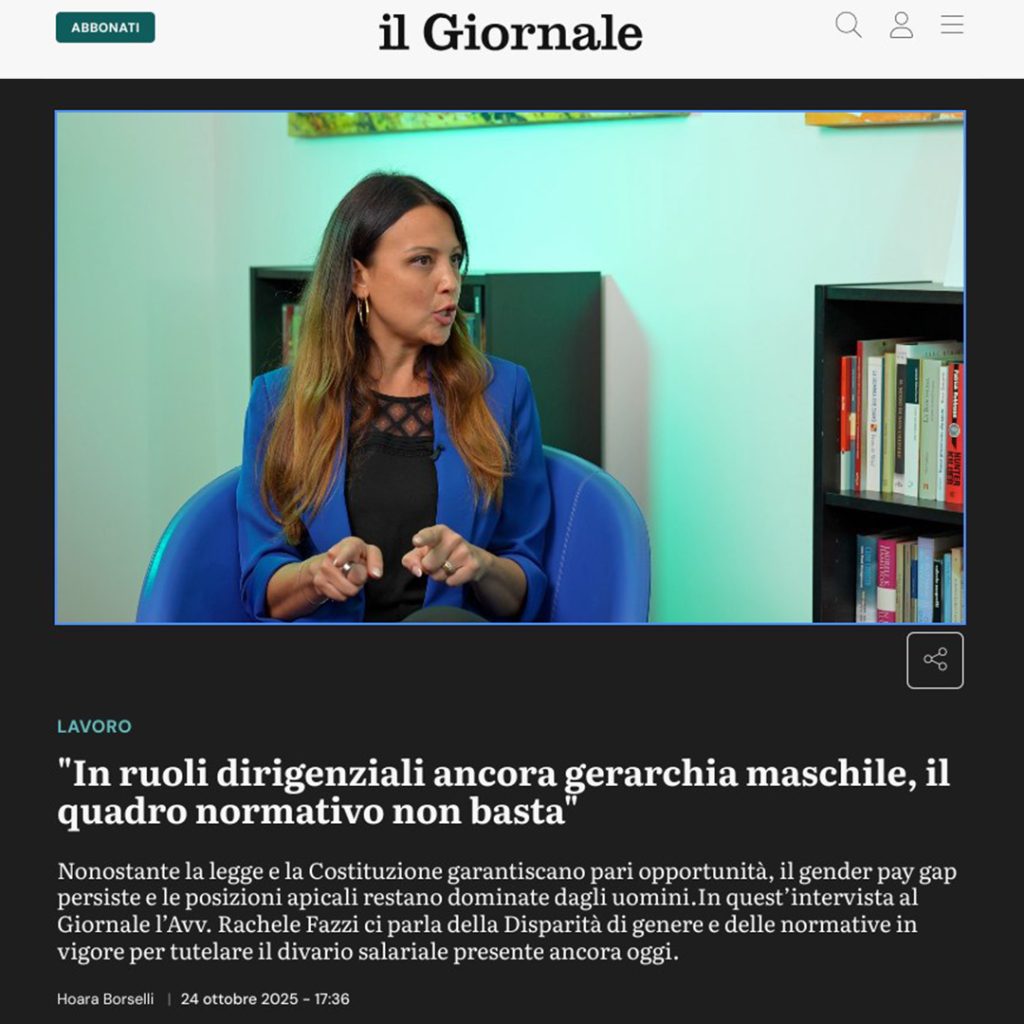Oggi esaminiamo una sentenza della Corte di Cassazione della sezione lavoro, la Sentenza n. 24201 del 29 agosto 2025 che stabilisce come il recesso intimato per mancato superamento di un patto di prova affetto da «nullità genetica» configura un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto materiale
Come mai questa ordinanza della cassazione è così rilevante e quali sono gli aspetti innovativi?
La sentenza in esame riguardante il caso di una lavoratrice che aveva chiesto l’accertamento della nullità del patto di prova per l’assoluta genericità dello stesso, con conseguente declaratoria di illegittimità del recesso intimatole per asserito mancato superamento della prova.
L’aspetto innovativo di questa sentenza è rappresentato dall’aver affrontato il problema delle conseguenze della nullità genetica del patto di prova avendo riguardo al cambiamento giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui, ove dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, ometteva di applicare la sanzione della reintegrazione – già prevista per il licenziamento disciplinare – anche a quello per asserito (e indimostrato) giustificato motivo oggettivo.
La Suprema Corte, in primo luogo, ha ricostruito la materia ricordando che, in ipotesi di nullità genetica del patto di prova contenuto nel contratto individuale di lavoro, come può essere il caso della mancata stipula del patto di prova per iscritto in epoca anteriore o almeno contestuale all’inizio del rapporto di lavoro oppure il caso della mancata specificazione delle mansioni da espletarsi (come si era verificato nella vicenda esaminata), a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2015 (cd. Tutele crescenti applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015), si determina la automatica conversione dell’assunzione in definitiva sin dall’inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall’art. 1419, comma 2 cod. civ. sicchè venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall’art. 1 L. n. 604 del 1966.
Pertanto, in presenza di un patto di prova invalido, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina dei licenziamenti dettata dalle legge n. 604 del 1966. In buona sostanza, il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo ed alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1, del predetto D.Lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.
Di assoluto rilievo, quindi, che la Cassazione abbia rivisto tale impostazione alla luce dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 che, nel riallineamento delle tutele ivi previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e per giustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall’altro, consente di ritenere il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto.
A livello pratico quali sono i risvolti per i lavoratori?
L’ambizione è che i giudici di merito, facendo proprio il principio di diritto affermato in questa sede della Suprema Corte di Cassazione, nel momento in cui rilevino che il lavoratore è stato raggiunto da un illegittimo provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro per effetto del mancato superamento di un patto di prova affetto da «nullità genetica», tutelino il lavoratore disponendone la reintegra.
Difatti, per effetto della sentenza in esame, il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice, sicchè la sanzione applicabile deve essere identica a quella prevista nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato e di insussistenza del fatto economico, ovvero la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 23/2015, come costituzionalmente interpretato dalla Consulta con la sentenza 128/2024.